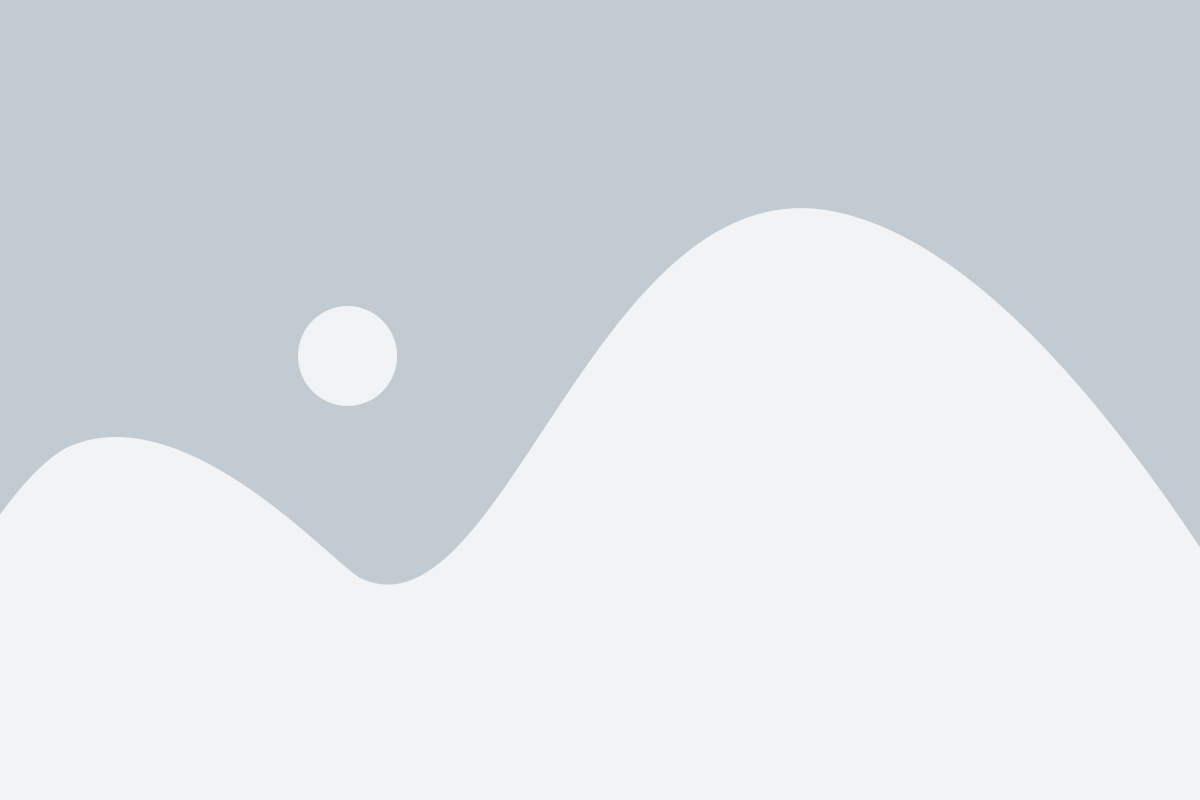Coloro che vanno in piazza gridando, sbandierando la pace e assaltando le camionette dei carabinieri danno sfogo alla loro lotta politica ma, se si dà loro ascolto e se hanno il tempo di risalire alle radici dello scontento parlano del loro vissuto in famiglia. Infatti, spesso lo sdegno contro la società si sposa con la critica ai genitori e in particolare alle madri, da cui si ritiene, a torto o a ragione, di non essere stati amati adeguatamente. Chi non ha goduto delle cure materne fa fatica a costruire da adulto il proprio equilibrio psichico, come attestano le diverse scienze collegando quel rapporto originario con la formazione dell’identità, della stabilità e del mutamento nel tempo. Perciò, per affrontare il tema della speranza, calibrandola sulle singole storie di vita, occorre riandare al rapporto tra feto e madre in gravidanza.
Anche dal punto di vista della donna la maternità è una sfida all’identità. Si pensi agli studi psicologici e psicoanalitici sulla depressione post partum, sulla sindrome di Medea, sui disturbi bipolari, le dipendenze, i traumi. Il rapporto inizialmente gerarchico – la mamma ha un’ovvia autorità sul figlio, in una reciprocità asimmetrica nei confronti di chi è del tutto dipendente fisicamente e psicologicamente – pian piano si trasforma. Il tasso di autorità si abbassa ma non è scontato che la dipendenza si trasformi in sorellanza nutrita di rispetto, solidarietà e gratitudine.
Particolarmente delicato e complesso è il rapporto con la figlia quando la bambina inizia a confrontarsi con la madre come riferimento per costruire la propria identità femminile. Numerosi studiosi si sono interrogati su questi cambiamenti. Freud, in relazione alla costruzione della sessualità, spiega che la figlia pian piano deve separarsi dalla madre e spostare il suo “oggetto d’amore” sul padre. C’è da mettere in conto il disturbo oppositivo provocatorio, che porta la bimba a opporsi con ostilità alla figura che rappresenta l’autorità. Per non parlare della gelosia per l’arrivo eventuale di un fratellino o una sorellina e del rifiuto di quei dettati materni che riflettono aspirazioni mancate di mamme convinte di sapere cosa sia bene per le proprie “creature”. Può accadere che la madre venga idealizzata come modello irraggiungibile e dunque amata e odiata, e la ragazza provi a distaccarsene tra rabbia e sensi di colpa per le aspettative deluse. Sta di fatto che non di rado le adolescenti rimproverano alle madri un comportamento castrante, se non aggressivo e violento, che bloccherebbe lo sviluppo della loro personalità. Il periodo in cui i disturbi si acuiscono è l’adolescenza, quando la figlia inizia il suo percorso verso l’autonomia e spesso cova conflitti latenti o patenti in un gioco negativo di accuse reciproche. Quando si stabilisce un rapporto disfunzionale, le conseguenze sono pesanti nella gestione delle emozioni e nelle relazioni sociali. Non a caso gli studiosi collegano livelli elevati di criticismo genitoriale a problemi psicologici (ansia, depressione) e relazionali.

Ognuno deve fare i conti con la propria storia. Ogni figlio e ogni figlia quando elaborano il bilancio del rapporto con i genitori hanno qualcosa da perdonare e qualcos’altro da farsi perdonare. Vi è chi ha ricevuto amore e chi si è sentito trascurato o abbandonato, chi ha sofferto per un fratello o una sorella preferiti e ha dovuto faticare per guadagnarsi la stima dei genitori, chi è stato impedito di seguire la propria strada e la propria vocazione. Nessuno può dire di non essere stato ferito qualche volta dalle mancate cure che avrebbe desiderato.
Ciascuno ha il proprio modo di elaborare il dolore. Non sono pochi gli adulti che non riescono ad elaborare le ferite dell’infanzia e continuano a rimuginare veri o presunti torti ricevuti dal comportamento delle madri e dei padri, inquinando il buon essere proprio e dei propri cari. Eppure con la maturità bisognerebbe lasciarsi alle spalle le recriminazioni sul comportamento materno. Per essere felici bisognerebbe abbandonare i risentimenti, imparare a perdonare eventuali errori, a dosare le parole, a ingentilire i comportamenti, ad essere accudenti rivolgendo uno sguardo amorevole e misericordioso ai limiti della madre, specie se, avanti con gli anni, quando ha più bisogno di quella tenerezza che attenua le sofferenze della curva calante della vita.
Per guardare avanti, riattivare il protagonismo creativo e mettere in circolo l’amore con e per gli altri, occorre stoppare i brontolii adolescenziali, evitare di indugiare sul passato per riaprire i dialoghi interrotti, mettere in discussione convinzioni e comportamenti, tenere conto dei limiti reciproci, valorizzare le risorse, scusare gli atteggiamenti vissuti come frustranti. Se le ferite non vengono rimarginate, imputridiscono e ci si porta dietro il peso di una figliolanza ingrata, che si riversa a cascata sulle nuove generazioni. Come ha scritto M. Vaillant: “Il perdono accordato ai nostri genitori è una promessa fatta ai nostri figli”.1
Non si tratta solo di ostentare atti di amore gentili e di buona educazione, ma di immedesimarsi profondamente nelle loro storie di vita, di fare uno sforzo di comprensione amorevole che conduca all’apprezzamento per il valore di quell’essere unico che ci è stato dato per genitore e che rivela a noi un volto inedito dell’essere. Neanche si tratta di eliminare la distanza che inevitabilmente c’è non solo tra generazioni e culture diverse, ma più radicalmente tra le diverse vocazioni stampate da Dio nella creazione. L’amore a cui si allude non è simpatia o antipatia, unità fusionale, che non protegge l’identità dell’altro e dunque anche la propria. Del resto, se possiamo comprendere e condividere le esperienze altrui, non possiamo viverle allo stesso modo in prima persona. Per i genitori verso i figli e viceversa, l’altro rimane altro, perché radicato autonomamente nell’essere.

Non è facile per gli adolescenti liberarsi di quegli schemi mentali diffusi nelle conversazioni tra pari, che definiscono i genitori retrogradi e inadeguati al mondo contemporaneo. Tutti utilizziamo schemi mentali indispensabili a ridurre la complessità quando assembliamo i dati dell’esperienza per costruire categorie-guida che selezionano le informazioni e le rievocano all’occorrenza. Tali schemi, tuttavia, tendono ad auto-confermarsi e a cristallizzarsi in stereotipi a difesa del proprio gruppo di appartenenza: un “noi” contrapposto al “voi”. Gli stereotipi inquinano anche le relazioni familiari perché valutano l’altro in base alla categoria di appartenenza, cadendo in discriminazioni mentali e comportamentali. Proprio la distanza rispettosa delle variabili che tratteggiano le differenze (età, sesso, studi, storie di vita) obbliga a fare all’occorrenza un passo indietro per modificare le proprie prospettive in relazione al tu che si ha di fronte.
Le problematiche irrisolte del rapporto madre-figlia si riflettono sui rapporti con le altre donne e danno luogo a quelle narrazioni dei media, zeppe di donne litigiose per gelosia, per il primato della bellezza, del successo e del potere. Altro che sorellanza! Non è più il caso di credere nella solidarietà automatica tra donne, come si è fatto nel ’68, esaltando la complicità di genere. Ogni relazione, tra donne e uomini e tra donne e donne, richiede di essere costruita pazientemente e intenzionalmente nel tempo, calibrando la comunicazione, intuendo quando è il tempo di parlare o di tacere, incassando e andando oltre qualche offesa, riconoscendo e valorizzando i talenti altrui.

Come sostiene Papa Francesco in Spes non confundit, «La speranza nasce dall’amore» (SNC, n. 3). L’amore nasce dal sentirsi amati: la fede è la risorsa preziosa di chi si sente amato da Dio e confida in quel gettito inesauribile di vita buona che viene dall’alto (il Papa precisa che la speranza: “si fonda sull’amore che scaturisce dal Cuore di Gesù trafitto sulla croce”, SNC, n. 3): «Abbiamo bisogno di una felicità che si compia definitivamente in quello che ci realizza, ovvero nell’amore, così da poter dire, già ora: ‘Sono amato, dunque esisto; ed esisterò per sempre nell’Amore che non delude e dal quale niente e nessuno potrà mai separarmi’» (SNC, 21).
La vita sociale e politica richiede un amore non sentimentalistico, ma carico di creatività, rispetto, accoglienza delle differenze e delle idee migliori dell’altro. Per sperare in un mondo più solidale, non resta che guardare a San Francesco, che di sorellanza e fratellanza se ne intendeva.
- M. Vaillant, Perdonner à ses parents. Il n’est jamais trop tard pour se libérer des cecrets de famille, Pocket, Cher 2004, p. 248. ↩︎