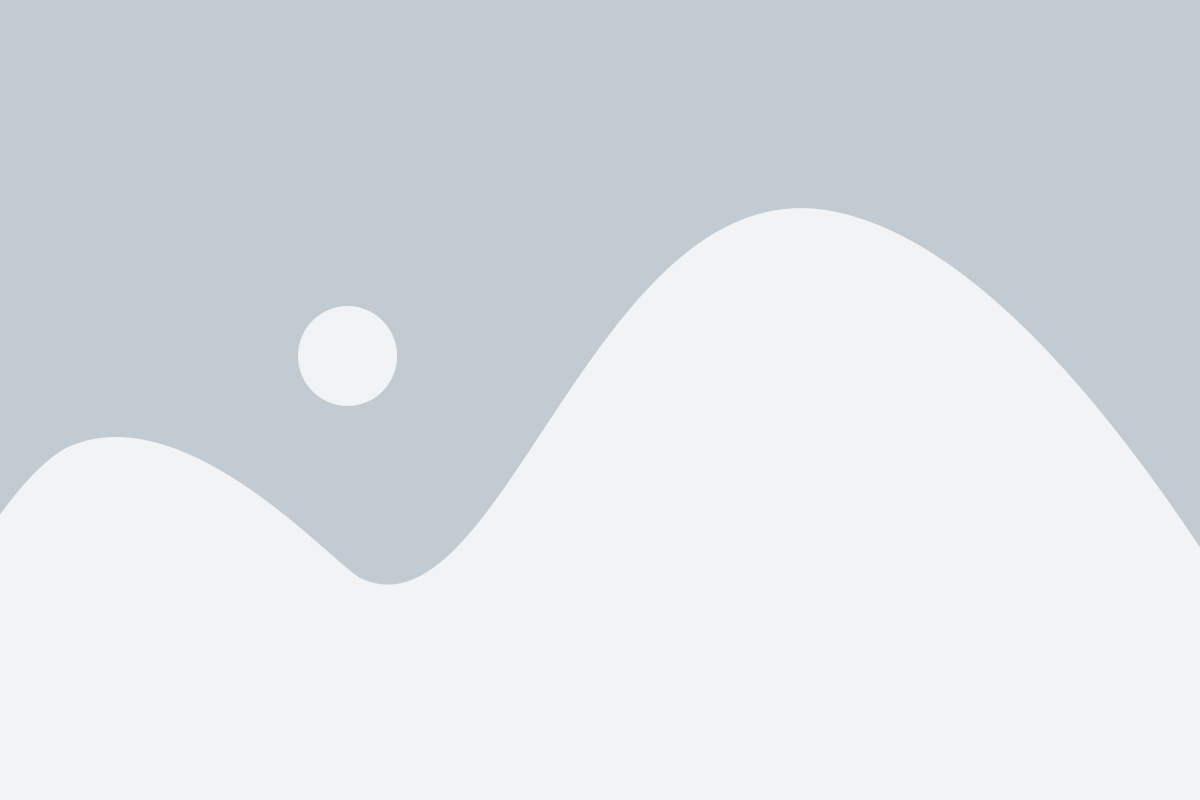Nella lettera ai giovani del 2003 Fr. Roger di Taizè scriveva: «Fra le giovani generazioni in tutto il mondo, numerosi sono coloro che si interrogano: esiste una speranza per il nostro futuro? Come passare dalle inquietudini alla fiducia? Con la povertà in continua crescita, l’avvenire dell’umanità è incerto. C’è la sofferenza di molti bambini, ci sono tante rotture che feriscono i cuori. Tuttavia, non vediamo sorgere perfino nelle situazioni fra le più inquiete del mondo dei segni di un’innegabile speranza?»
Ancora oggi i giovani condividono le loro preoccupazioni per il futuro: quale speranza ci guiderà, quali riferimenti saranno affidabili quando tutto è così instabile e precario? Per quale scopo vale la pena vivere? Come approcciarsi serenamente al futuro e governarlo nel segno della speranza?
Dinanzi alla realtà drammatica e critica che stiamo vivendo a tutti i livelli, non possono bastare ricette semplicistiche offerte da chi coltiva un ingenuo ottimismo. In situazioni di emergenza noi cerchiamo abitualmente ragioni di senso e di speranza, prospettive di futuro, relazioni di accoglienza reciproca che consentano il dialogo tra adulti e giovani, tra le diverse generazioni che si susseguono nella storia fino al presente e quelle che si aprono all’avvenire. Si richiede un atteggiamento di fiducia che da sempre nutre la speranza, una fiducia che apra al futuro, che creda nella vita, nelle energie vitali presenti nel mondo e in ogni persona. Ma l’esercizio della fiducia, che consente di confrontarci serenamente con il presente e con il futuro, è impensabile anzi impraticabile senza la speranza, senza cioè promuovere la formazione dell’attitudine alla speranza.
Qui sta la sfida: abbiamo bisogno di speranza, soprattutto quando l’incertezza e la precarietà, che sembrano essere divenute una ‘normalità’, insidiano notevolmente ogni dinamismo che rimandi alla speranza. Di fatto, la domanda sulla speranza affiora sempre nei tempi difficili, specie in contesti di estrema complessità carichi di incognite per il futuro.
Speranza è apertura al futuro
Speranza e futuro: due parole chiave che possono delineare il cammino della Chiesa, della vita consacrata e dell’educazione giovanile, qui e ora, e nei tempi dell’avvenire. È provvidenziale quindi, in questo anno giubilare, l’appello a guardare al futuro con speranza superando ogni forma di scetticismo e pessimismo. L’impossibile speranza cui tutti guardiamo e che desideriamo, si apre dinanzi come possibilità e come proposta che va oltre le avversità e le incertezze del momento presente.

«Torniamo a sperare» – ci esorta il poeta – e apriamoci al futuro senza rimanere prigionieri del passato né degli affanni del presente.
Di fronte alla crisi del futuro, alla sofferenza e al dolore che ci sorprendono quando facciamo l’esperienza della perdita e della separazione, della malattia e della morte oppure dinanzi a tragici eventi, come devastazioni, guerre, pandemie, alluvioni e terremoti, quale speranza e quali orizzonti di senso possiamooffrire alle nuove generazioni? Non tutti hanno la capacità di resistere e di sopportare il peso delle avversità. In che modo accompagnare i giovani, tentati di lasciarsi andare, di lasciar morire la speranza privandosi della possibilità di aprirsi al futuro?
Imparare a sperare in un mondo in “crisi di speranza”
La società contemporanea, come rilevano i sociologi, vive una fase di grande regressione a motivo della congiunzione di tre crisi: la crisi del futuro divenuto più incerto e inquietante, la crisi causata dalla mondializzazione accelerata di tipo tecnico-economico, la crisi della civiltà per lo smarrimento dei valori, l’individualismo e la tecnocrazia con la conseguente perdita delle relazioni, l’incremento della solitudine, ma anche del degrado ecologico e del deterioramento della qualità della vita.
Uno degli esiti più drammatici del profondo radicale cambio culturale è la perdita delle ragioni di senso e di speranza, di prospettive di futuro ma anche di responsabilità del presente soprattutto in ambito educativo.
La crisi della speranza, che non ha risparmiato neppure la fede cristiana, è evidente a livello antropologico, laddove la speranza è vista come un dinamismo tipicamente umano che spinge la persona nella direzione di qualcosa che esprima pienezza di vita e di senso. La speranza, difatti, si configura come una risorsa psicologica formidabile per la crescita integrale della persona e necessaria per ogni cambiamento personale e sociale, perché non è solo attesa ipotetica di qualcosa che si desidera realizzare, ma è una decisa volontà di costruire il futuro secondo una progettualità intravista e che conduce alla realizzazione di sé. Ciò significa che la speranza non consiste nel perseguire illusioni ma nell’assumere consapevolmente gli ostacoli, nel superare le sfide del presente in vista di una pienezza di compimento nel futuro. Si tratta di una «speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino» (Spe Salvi 1).
Viene spontaneo chiedersi: come rigenerare la speranza in un mondo in cui la fiducia e l’affidabilità sono sempre più a rischio? L’eccesso di fiducia in sé o l’eccesso di sfiducia rendono questo processo di rigenerazione, di per sé già faticoso, ancora più difficile. Dinanzi a un presente dominato da conflitti, catastrofi ambientali, incertezza e all’imprevedibilità del futuro si generano sentimenti contrapposti, tra paura e fiducia, ansietà e preoccupazione, dubbio e voglia di fuggire, per cui guardare l’avvenire con ottimismo appare un’impresa veramente ardua. Tuttavia, anche questa esperienza si sta rivelando ricca di risorse e di sollecitazioni positive. Infatti, quando c’è un’emergenza sovente si sviluppano delle forze positive di miglioramento, di resilienza, di solidarietà e cura dell’altro, di speranza per il futuro. In questa crisi abbracciare la speranza è mantenere viva la tensione verso la prospettiva futura, ed è proprio il futuro che ci viene incontro come spinta ed esigenza di cambiamento.
Abitare il futuro per far fronte al cambiamento
Per abitare il futuro non c’è altro modo che imparare ad abitare la speranza per non rischiare di bloccare l’irruzione del futuro verso le generazioni che verranno, verso la vita che deve svilupparsi e raggiungere nuove forme di fraternità e di solidarietà.
Se ci collochiamo in una prospettiva di fede, a partire dagli esiti sognati, la speranza sollecita a impegnarci per costruire insieme tale futuro perché abbiamo la certezza della presenza di Qualcuno che guida la storia, che è possibile andare oltre ogni difficoltà e prova, per cui anche il cambiamento e la precarietà in ogni ambito dell’esistenza non impediscono allo Spirito di darci delle indicazioni per un cammino possibile.
Ciò vale anche per la vita consacrata fortemente interpellata dalle frequenti crisi che la fanno entrare in fibrillazione, con evidenti ricadute sulla fedeltà e perseveranza, ma soprattutto sulla formazione delle nuove generazioni. È indispensabile educare a vivere la speranza innanzitutto come attitudine umana ed esistenziale, prima che come realtà teologale, come dono dello Spirito presente e operante nella storia. Ma bisogna porsi in stato di discernimento, di ascolto attento e profondo della realtà per comprendere quali sono gli snodi, i passaggi difficili e cruciali, ma anche le risorse disponibili, gli elementi positivi e i fattori che concorrono a rendere più consistente la visibilità della vita consacrata e ne potenziano l’attrattività dinanzi al mondo, in particolare ai giovani.

Essere attenti ai segni di speranza
Siamo chiamati a spostare l’attenzione e l’interesse sul futuro, più che sul passato, pur nella consapevolezza che le radici, come fattore di stabilità, esigono fedeltà incondizionata alla persona e alle relazioni, ai valori essenziali del carisma. Ma in una visione dinamica oltre a comprendere la realtà presente occorre interrogarsi su cosa avverrà domani, su quali processi e quali sono i criteri che potranno guidarci nel futuro.
I giovani, ma anche gli adulti e chiunque crede nell’educazione come atto creativo che genera il futuro, come spazio di crescita e rigenerazione, cercano innanzitutto ragioni sicure per fondare senso e speranza nella dinamica del dare vita. Educare non è forse dare al presente il respiro della speranza, scommettere sul futuro prestando attenzione alle progettualità esistenziali? Per questo, più che tornare al passato occorre tornare al futuro, cioè tornare a crescere, pur nelle vecchie e nuove configurazioni che hanno caratterizzato le origini e hanno disegnato l’attuale situazione. Continuare ad essere strumenti di vita e di pace, partecipando attivamente mediante il lavoro, la dedizione e le difficoltà della vita, alla tormentata vicenda umana e sociale degli uomini e delle donne del nostro tempo, totalmente coinvolti nel tessuto ecclesiale e culturale, a servizio della vita e della promozione dei diritti umani, specie dei più poveri. Ci vuole un nuovo coraggio e di una chiara e prospettica visione della vita, del mondo e della stessa vocazione, per attivare dinamismi di fiducia nel mondo di oggi che sembra aver perduto la speranza, con l’ostinazione del costruire insieme e dello sperare… “contro ogni speranza”.