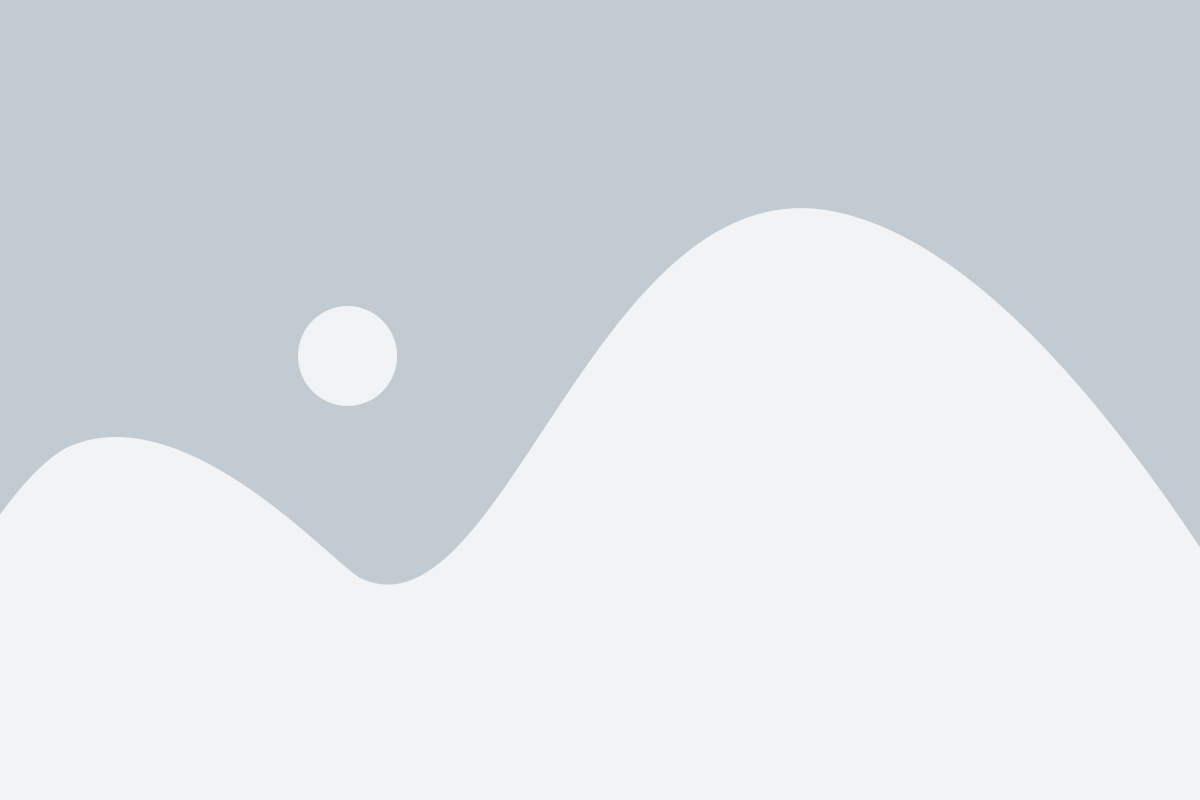Sono nato in Rwanda, a Nyamasheke. Oggi vivo con la mia famiglia a Milano, dove sono insegnante di religione cattolica. Sono passati 30 anni dal genocidio dei tutsi in Ruanda. All’epoca avevo dieci anni ma me lo ricordo come se fosse ieri. È stato ucciso mio padre, come tanti miei familiari, amici e conoscenti. Raccontare quello che ho vissuto durante il genocidio ha per me un solo obiettivo: dopo avere letto questo articolo, chiediti cosa fai oggi per un mondo migliore. Ognuno, nel suo quotidiano, può fare qualcosa e sono le piccole cose che cambieranno il mondo.
Alcune cose si vedono solo con gli occhi che hanno pianto. Sono convinto che guardando indietro, nella nostra storia personale, troviamo un momento in cui non eravamo nessuno, siamo stati disprezzati, ignorati e qualcuno ha vissuto momenti che spesso diventano difficili da raccontare. Mi vengono in mente le parole di Pietro: “Quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio” (1Pt 2, 10). “Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica” (Lumen Gentium, 9). Grazie al dono prezioso della fede in Cristo – Lui, l’unico capo del popolo – sento forte il compito di raccontare al mondo ciò che Lui ha fatto per me e in me.
Sono nato in una famiglia di credenti cattolici. Recitavamo il rosario tutte le sere. Nel mio villaggio si respirava un’aria di serenità. Andavo alla scuola primaria con altri bambini del villaggio, senza essere accompagnati dai genitori, perché la gente si voleva bene. Si giocava insieme, si studiava insieme, insomma, tutto era apparentemente bellissimo. L’unico brutto ricordo dell’infanzia era l’inizio dell’anno, quando bisognava compilare le schede di identità (amafishi). Chiamavano tutti i bambini e nominavano l’etnia di ciascuno. Questo per me era un momento da incubo. Gli insegnanti sapevano che essere tutsi comportava avere meno diritti, ma era un’ingiustizia “normalizzata”, a cui nessuno faceva più caso. Ti chiamavano tutsi e ti tenevi la tua frustrazione. Tutti sapevano che essere tutsi voleva dire essere esclusi in tanti posti di lavoro.
Questa realtà mi torna in mente ogni volta che vedo alcuni studenti a scuola senza la cittadinanza italiana, pur essendo nati e cresciuti in Italia. Questi ragazzi sono esclusi dalla legge, che li considera stranieri nel Paese in cui sono nati e cresciuti. Ma, come nel Rwanda prima del 1994, queste discriminazioni profonde non vengono notate, sono percepite appieno solo da chi le vive o le ha vissute. Apparentemente non ci sono problemi. Si gioca insieme, si mangia insieme, insomma, si è tutti uguali. Ma è davvero così? Pensate a cosa significa per un ragazzo adolescente essere fermato dalla polizia che gli chiede il permesso di soggiorno nel Paese in cui è nato. Non sembra vero, ma purtroppo questa è la verità ed è uno dei tanti motivi che mi spingono a raccontare la mia storia.
Spesso si sente parlare delle apparizioni della Madonna. Alcuni ci credono, altri fanno fatica a crederci. Il genocidio dei tutsi in Rwanda era stato preannunciato dalla Madonna. Per ben otto anni, dal 1981 al 1989, la Madonna è apparsa a Kibeho, un villaggio nel sud del Rwanda, e ha scelto di dialogare con tre ragazze, Alphonsine, Marie Claire e Nathalie: a loro ha mostrato, tra le altre cose, mattanze, stupri e cumuli di cadaveri mutilati per le strade. Aveva chiesto a tutta la popolazione di convertirsi e di pregare per allontanare il male. Mia madre mi racconta dei lunghi viaggi che facevano negli anni ’80 per andare ad ascoltare i veggenti. Il messaggio della Madonna, purtroppo, non è stato ascoltato. Quelle apparizioni, poi riconosciute dalla Chiesa cattolica nel 2001, sono state drammaticamente profetiche, perché hanno anticipato il genocidio dei tutsi che nel 1994 ha devastato il Paese.

Era il periodo delle vacanze di Pasqua, quando verso le ore 20.30 del 6 aprile 1994 l’aereo del Presidente del Rwanda è stato abbattuto. Le scuole erano chiuse e noi eravamo tranquilli a casa. Noi eravamo sette figli, mio padre era commerciante e mia mamma casalinga. Eravamo cattolici, come più del 60% della popolazione del Rwanda dell’epoca. Il 7 aprile la radio comunica la notizia dell’abbattimento dell’aereo presidenziale. È l’inizio della paura. Il giorno dopo iniziano ad arrivare voci di eccidi da parte degli hutu contro i tutsi. Fuggiamo, lasciando il cibo caldo sulla tavola, e ci troviamo travolti da una fiumana di gente impazzita. È l’ultima volta che vedo mio padre. Nella confusione la famiglia si sparpaglia. Mi dirigo verso l’unico luogo conosciuto: la parrocchia di Shangi, che dista qualche ora di cammino dal villaggio. Siamo in tanti, ma senza nessuno della mia famiglia. Arrivo in parrocchia stremato, trovandola affollatissima, ma riesco a riabbracciare il mio fratellino Vincent e alcuni cugini, Bertin, Kazungu, Theobald e Martin. I feriti raccontano di aver incontrato la furia omicida degli interahamwe, una milizia paramilitare hutu. Per giorni rimaniamo asserragliati senza cibo né acqua. Gli hutu avevano circondato la parrocchia e reciso i tubi dell’acqua. Per sopravvivere mastichiamo foglie di banano, ogni tanto proviamo a uscire travestiti da bambine per chiedere l’elemosina. E recitiamo il rosario. Dopo molti giorni, alcune suore hutu riescono a portarci via di nascosto. Rischiano la vita per metterci al sicuro nel loro convento. Lì c’è l’acqua, anche se il cibo è poco e razionato. Ma la quiete dura poco. Il 29 aprile, un gruppo di miliziani assalta di nuovo il Paese. Ancora una volta corro fuori e mi ritrovo a terra tra i morti, i feriti che urlano aiuto e gli interahamwe che li freddano. Sono sopravvissuto, e di questo ancora oggi ringrazio Dio. La cronaca di quei mesi è dolorosa, ma aiuta a capire molte cose.
I politici, tramite la radio, che era il mezzo ufficiale di comunicazione più usato durante il genocidio, hanno convinto gli hutu a uccidere, senza risparmiare nessuno. Iniziavano la mattina e tornavano a casa la sera, stanchi. Lo chiamavano lavoro. Avevano creato dei blocchi in tutte le strade: chi passava, doveva mostrare la carta d’identità. Chi aveva la carta d’identità su cui era scritto “tutsi” veniva ucciso subito. Ho trovato rifugio in casa di Maria e Silas, due hutu che non accettavano quanto stava accadendo. Se sono qui a scrivere, è perché loro mi hanno nascosto per qualche settimana. Lì ho saputo che mia madre e i miei fratelli erano vivi, e questo ha risvegliato la mia speranza. Sono rimasto nascosto da Maria e Silas per diversi giorni, finché non è diventato troppo pericoloso, perché nel villaggio iniziava a girare voce che ospitassero dei tutsi in fuga. Mi hanno dunque proposto di raggiungere il campo profughi di Nyarushishi. Qualche giorno dopo, miracolosamente, mi hanno raggiunto mia madre e i miei fratelli.
In quel campo di Nyarushishi, la vita era molto difficile, ma almeno si poteva godere della luce del sole. Cosa che sembrava un sogno. A luglio è arrivata la notizia della vittoria del Fronte patriottico ruandese: i massacri sono cessati e ben presto il campo è stato evacuato. Ci hanno detto di tornare alle nostre case, ma non c’era più nulla: le nostre case erano state rase al suolo fin dalle fondamenta. Il tessuto sociale rwandese era letteralmente distrutto. Potevamo, però, vedere la solidarietà che animava tanti: ci si dava una mano, gli orfani erano accolti in famiglie che si allargavano sempre più e pian piano è iniziata la ricostruzione. Una ricostruzione che non passava soltanto attraverso l’edificazione di nuove abitazioni, ma anche e soprattutto attraverso l’instancabile lavoro della Chiesa rwandese per ricucire i rapporti tra la gente.
Tutto questo è durato tre mesi, da aprile a luglio del 1994. Il genocidio è iniziato dai rwandesi ed è stato concluso dai rwandesi stessi. La comunità internazionale ha guardato, ed è rimasta indifferente.

Nei cento giorni del massacro, Maria e Silas hanno aiutato oltre settanta persone e questo episodio è stato decisivo nel mio processo di perdono degli anni seguenti: loro, come anche quelle suore hutu, erano pronti a morire pur di aiutarci. Silas e Maria oggi sono riconosciuti come “giusti”, dalla ONLUS Gariwo1 che ha sede a Milano e collaborazioni internazionali.
Per questo creiamo Giardini dei Giusti in tutto il mondo e usiamo i mezzi di comunicazione, i social network e le iniziative pubbliche per diffondere il messaggio della responsabilità. Dal Parlamento europeo abbiamo ottenuto la Giornata dei Giusti, che ogni anno celebriamo il 6 marzo.


Nei giorni del genocidio non ci aggrappavamo alla fede per disperazione, era davvero vita per noi. Pregavamo il rosario costantemente. Continuavo a implorare Dio di non farmi morire, chiedevo di arrivare almeno al giorno dopo. Come avrebbe fatto mia madre a sopravvivere e a crescere da sola sette figli, se non fosse stata certa di un destino buono? Ha perso il marito, i fratelli e le sorelle, gli amici e, grazie appunto alla fede, ancora ringrazia Dio che non l’ha mai abbandonata. Nel 2023, al suo 50° anniversario di matrimonio, nonostante fosse riuscita a vivere con suo marito solo per 21 anni e altri 29 anni da vedova, ha chiesto al Santo Padre la benedizione del suo giubileo dei 50 anni di matrimonio perché suo marito è sempre presente nel suo cuore.
I sacerdoti, i vescovi, i religiosi e le religiose invitavano al perdono. E per noi significava perdonare i nostri vicini di casa che ci avevano attaccati. Ma è stato così, abbiamo perdonato. Solo così siamo riusciti pian piano a vivere. Il perdono a volte è l’unico mezzo per vivere. C’è stato un tentativo di fare giustizia, ma verso la fine degli anni Novanta, il Paese si è trovato di fronte a una situazione che non poteva continuare. Da una parte c’erano dei sopravvissuti che speravano di avere giustizia, ed era impossibile perché di fatto, quando un tuo caro è stato ucciso, non esiste nessuno e nessun’altra giustizia che lo riportino indietro. Dall’altra parte, però, c’erano i familiari degli assassini che portavano da mangiare ai loro parenti in carcere, in quanto il paese era povero e lo stato non poteva mantenere tutti i carcerati. La Chiesa cominciò con il “gacaca nkirisitu” cioè gacaca2 cristiana.


Una seduta in un gacaca a Ruhango, febbraio 2007.
I Vescovi avviarono incontri di dialogo tra i familiari delle vittime e gli autori del massacro. Ci si incontrava nelle “comunità ecclesiastiche di base” (imiryangoremezo). A partire dalla Parola di Dio, letta e meditata insieme, si cercava di creare dei dialoghi veri e sinceri.
Poi all’inizio del 2000 lo Stato decise di assumere la realtà del gacaca e si riuscì a creare un dialogo tra gli assassini e tutta la comunità. Il gacaca (letteralmente “erbaccia su cui ci si siede nel cortile”), è un’usanza che era in atto prima del colonialismo, ogni volta che c’erano dei conflitti. La famiglia della vittima si sedeva da una parte e la famiglia del presunto colpevole si sedeva dall’altra e si cercava di trovare una soluzione insieme. Si applicava la stessa usanza. I genocidari andavano nel villaggio e chi chiedeva scusa veniva liberato.
Ovviamente lo scopo principale era quello di trovare una via di uscita, di trovare delle soluzioni che permettevano al Rwanda di andare avanti. Oggi, assassini e vittime si trovano una volta alla settimana in casa ora dell’uno, ora dell’altro per pregare insieme, commentare il Vangelo e fare qualche gesto di carità.
Perdonare non è qualcosa di teorico. Bisogna sperimentarlo. Nel 1997, tre anni dopo il genocidio, ho iniziato il liceo presso il “Petit seminare Saint Aloys” a Cyangugu. Nel mio cuore pesava una promessa fatta a Dio durante i giorni del genocidio: “Se mi salvi, mi faccio prete”. Ma il buon Dio, aveva piani diversi su di me. Al liceo incontrai Pino (nome di fantasia), cugino di Marie Louise. La sua storia mi colpì moltissimo. Era hutu. Quel ragazzo viveva lo stesso mio dolore: io ero orfano di padre, ma suo padre era in prigione e sua madre, tutsi, i cui familiari erano stati uccisi, esattamente come la mia, faticava a mettere il cibo in tavola, era costretta ai lavori più massacranti per portare avanti la famiglia da sola. Anche il suo dolore aveva valore, non esisteva solo il mio. Un giorno sono venuti a lavorare in seminario dei carcerati: c’erano tra loro molti responsabili del massacro, e tra questi suo padre. Alla fine dell’anno scolastico andai a trovarlo a casa: scoprii che la madre era una tutsi alla quale avevano sterminato la famiglia ma lei era stata risparmiata perché sposata con un hutu. Non potevo immaginare la sofferenza del cuore di Pino, lacerato in due come un’intera nazione.

Mi sono diplomato nel 2004. Io ed altri 14 compagni abbiamo chiesto di entrare nel seminario maggiore per diventare preti. Il mio vescovo ha mandato dieci di noi a studiare a Rutongo, in Rwanda, altri due a Roma e un altro insieme a me a Reggio Calabria. Nel 2005 è iniziato il mio percorso verso il sacerdozio ministeriale in Italia, precisamente in Calabria. A un certo punto, però, è nato in me il desiderio di formare una famiglia e la conseguente scelta, maturata nel tempo e guidata dai superiori e dal Vescovo, di lasciare il seminario. Rientrato in Rwanda, ho ritrovato Marie Louise, che studiava per diventare infermiera. Anche per lei gli anni dopo il genocidio sono stati un periodo faticoso, ma di maturazione. Ci siamo fidanzati e pian piano abbiamo deciso di sposarci. Non è stato facile dire alla mia famiglia che avrei sposato una hutu. Il padre di lei, poi, era morto fuggiasco in Congo e questo rendeva le cose ancor più difficili. Alcuni parenti mi tolsero il saluto, mi accusarono di aver dimenticato i crimini commessi dalla sua etnia. Eppure il nostro amore, accompagnato e guidato dal buon Dio nella fedeltà alla preghiera e alla Chiesa, è stato più grande. L’amore che Dio mi aveva insegnato in quegli anni mi ha permesso di andare oltre a tutto. Ci siamo sposati nel 2013, oggi abbiamo due figli, Samuel e Davide, e possiamo affermare che le cose che uniscono hutu e tutsi sono molte di più di quelle che li separano. Ma abbiamo dovuto vestire l’uno i panni dell’altro per capirlo.
Per questo è necessario continuare a pregare: perché le parole della Madre del Verbo apparsa a Kibeho non cadano nel vuoto. Il genocidio è stato un richiamo alla conversione: quante opere, quanti carismi, quante cose buone sono state generate da quel dolore. Ho toccato con mano le conseguenze dell’odio, ma anche di quanto siano più forti il perdono e l’amore. Anche per questo ogni estate porto i miei studenti, colleghi e amici italiani in visita al Rwanda perché possano vedere con i loro occhi che ciò che separa gli uomini su questa terra è molto più piccolo di ciò che li unisce! La pace è possibile e si cerca solo con la pace.
- Gariwo è l’acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide, https://it.gariwo.net/ ↩︎
- I gacaca sono tribunali creati nel 2001, allo scopo di giudicare e assegnare eventuali pene agli accusati di crimini contro l’umanità, commessi durante il Genocidio del Ruanda del 1994. ↩︎

Sono passati 30 anni dalla caccia ai tutsi, giorno e notte. Sono morti oltre un milione di tutsi per mano degli hutu. Nel mio libro, “Nonostante la paura. Genocidio dei tutsi e riconciliazione in Rwanda” (Terre di Mezzo Editore), racconto quello che io e la mia famiglia abbiamo vissuto. Sono sposato con Marie Louise: prima del genocidio io appartenevo all’etnia dei tutsi, mentre Marie Louise all’etnia degli hutu. Pur avendo vissuto il genocidio in modi diversi, purtroppo, le conseguenze non hanno risparmiato nessuno.